L’avvento di tecnologie sempre nuove ridefinisce la prassi e destabilizza la norma. In un periodo di formazione per assorbimento passivo e insieme di infinite possibilità attive, la forma-libro può sembrare superata. Eppure eccoci qui a parlare di un libro, “Il metaverso – profili strutturali, socio-mediologici, economici e giuridici”, curato da Luigi Di Majo e Gino Frezza.
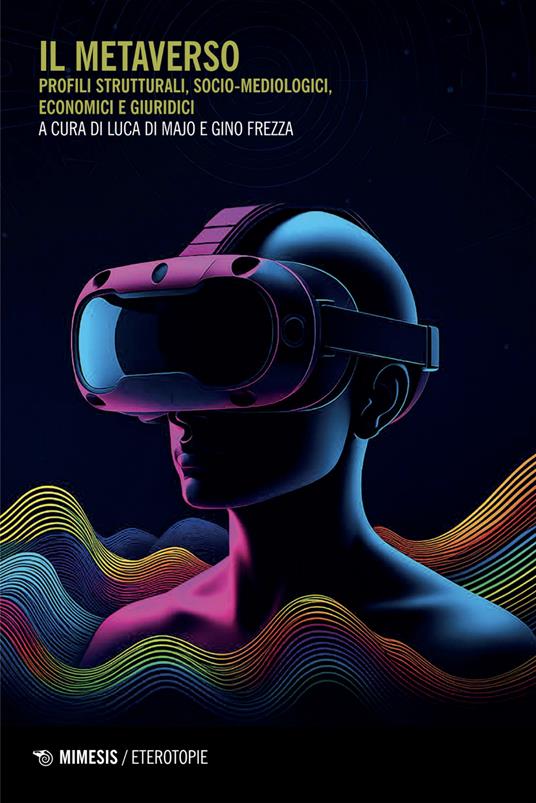
Nel mondo in cui l’informazione è frammentata e si perde facilmente in percorsi non lineari, la forma-libro si rivela la vera forza complessiva. In un contesto di divulgazione ampia, la linearità di esposizione agisce come una guida essenziale che impedisce al lettore di smarrirsi in un argomento complesso e variegato come il metaverso.
Non è il primo sull’argomento, né sarà l’ultimo. Il vero valore de “Il metaverso – profili strutturali, socio-mediologici, economici e giuridici” è il tentativo di superare i limiti di un’analisi puramente umanistica, naturalmente chiusa sull’insanabilità del conflitto tra progresso tecnologico e progresso umano, per una dialettica che non riesce a confrontarsi con la realtà concreta di un mondo plasmato da codice, mercati e modelli di business.
Certo, quasi 500 pagine e 36 euro non sono fattori trascurabili, per cui provo a riassumere le tre sezioni principal e quindi la loro utilità. L’Osservatorio metaverso è stato coinvolto da Di Majo, che ringrazio di aver accettato un testo sui gemelli digitali, inserito nella prima sezione, che parla di infrastrutture per il metaverso. Asintoti, prospettive e gemelli riscrivono il mondo, mostrando l’evoluzione che si espande incorporando elementi inaspettati. Il gemello digitale (digital twin) permette di creare modelli virtuali di oggetti, processi o sistemi reali, creando forme di metaverso più semplici da gestire di quelli con umani, ma anche immediatamente utilizzabili per migliorare settori produttivi. Questa tecnologia non si limita a simulare la realtà, ma la riscrive, consentendo di monitorare in tempo reale e di testare scenari alternativi in settori che spaziano dalla sanità all’industria. L’analogia di fondo della sezione è con la prospettiva geometrica del Rinascimento, suggerendo che anche il metaverso stia cambiando il nostro modo di vedere il mondo e interagire con esso.
La seconda sezione del volume, incentrata sui profili socio-mediologici, analizza le fluttuazioni del consenso intorno al metaverso, un fenomeno che alterna fascino e repulsione, plasmato dalle logiche di mercato e dalle dinamiche di potere. Il metaverso mira a far coincidere il vero, l’immaginario e il reale, ponendosi di fatto come una variante del fantastico, analoga alla finzione, ma osteggiato da fenomeni di privatizzazione, come la creazione di mondi chiusi che si manifesta principalmente in esperienze di gioco e consumo. Negli autori, si sente spesso lo scetticismo verso i cambiamenti tecnologici, avvertendo del rischio di derive anti-libertarie e del rischio di un isolamento a carattere collettivo.
La terza parte del volume, incentrata sui profili giuridici, affronta le tensioni legali e costituzionali generate dall’avvento del metaverso. Va rifiutata l’idea di un costituzionalismo digitale separato da quello esistente, sostenendo che le nuove tecnologie debbano essere affrontate attraverso l’applicazione e l’adattamento dei principi costituzionali esistenti, come la tutela dei diritti e dei valori democratici. Monetizzazione dei dati personali, fungibilità del diritto individuale e conflitto tra protezione costituzionale della corporeità fisica contro la corporeità digitale -probabilmente insieme alla citata privatizzazione dei mondi virtuali- rendono difficile, ma non impossibile, la definizione di una vera democrazia del metaverso.
Personalmente ho trovato importante che nessuno degli autori sia caduto nella trappola dell’hype del momento, l’intelligenza artificiale. Il risultato mantiene salda l’integrità del testo e in qualche modo ne allunga un po’ la vita attesa, per quanto possa vivere un saggio tecnologico.
In conclusione va osservato che le analisi proposte sono fortemente umanistiche, quindi partono da un sapere di base che viene ricordato e non spiegato. La necessità di descrivere, di analizzare la situazione, rimanda ad un eventuale, successivo volume per tradurre quel richiamo in azioni concrete, politiche e normative, capaci di orientare lo sviluppo del metaverso come opportunità da governare. Propongo quindi a Di Majo e Frezza la realizzazione di un seguito, magari titolato “Il metaverso – istruzioni per l’uso”.
